Mai nessun accendino venne perso
né dimenticato sul tavolo di un bar
né rubato
da qualcuno che ne era sprovvisto
davanti all’Enoteca Bellini.
Mai nessun accendino venne perso
né buttato
nell’indifferenziata
perché finito il gas
o finito in lavatrice
nella tasca dei pantaloni
Mai nessun accendino venne perso.
Sono ancora tutti qui
con me, alcuni
antichissimi, li tengo
dentro una scatola
nera di legno
laccata, rotonda
sul tavolo di cucina,
una scatola che nessuno
oltre a me ha il permesso di aprire.
Mai nessun accendino venne perso.
14.12.2025
Author Archives: OpereComplete
Io contro ChatGPT
Nei primi anni ’90 spuntarono a casa degli amici dei miei genitori i primi personal computer e capimmo subito che era l’alba di una nuova era. In una mansardina soppalcata ci sfondavamo di Prince of Persia, è vero, delle potenzialità infinite dei nuovi computer usavamo ben poco. “Questo è niente”, ci dicevamo con gli occhi che brillavano per la vicinanza con lo schermo, “è niente rispetto a quello che potremo fare in futuro”, ma intanto giù ore e ore a giocare a Prince of Persia. C’era in ballo una principessa da salvare in un castello, forse ne andava del destino dell’Occidente, non c’era proprio nulla da ridere. E quella musica ripetitiva, come una ghirlanda che si ripeteva sempre identica, incatenandoci e portandoci fuori dal tempo ordinario.
Continua a leggereDoriana mi ha raccontato che quando lei rimase incinta suo padre andò a caccia, o da un amico cacciatore, e portò a casa una lepre. Nelle campagne, ancora alla metà degli anni Ottanta, c’era la credenza secondo cui una donna incinta che avesse voglia di lepre avrebbe generato un figlio o una figlia con il labbro leporino, perciò si prendeva una lepre, si cucinava e si dava da mangiare alla donna.
Continua a leggereQuando finirà l’estate
(racconto uscito su Verde Rivista il 7.9.2018, editing V. Santoni)
Raquel centra le buche. Una dopo l’altra, tra auto parcheggiate e marciapiedi fino a piazza del Comune. Poi dietro-front. Raquel centra le buche. So che lo fa di proposito. Avanziamo lungo le strade nelle avare zone d’ombra dei palazzi. Fosse per Raquel non usciremmo neanche di casa. Per questo centra le buche: per farmela scontare. Ma sono io che pago e sono io che decido, quindi usciamo ogni giorno fino a raggiungere la piazza di Sesto. E poi dietro-front. Per strada poche persone, per lo più sono vecchi con sacchetti di plastica in mano e nell’altra quella delle rispettive badanti. Seguono percorsi che piuttosto che una meta sembrano avere come obiettivo l’unione di tanti puntini, come in quel gioco della Settimana Enigmistica. Sono le stesse ombre dei palazzi che percorriamo anche noi. Certi giorni Raquel spinge in silenzio, altri invece mi parla. Dice cose nella sua lingua madre che io non capisco, parole e frasi che forse non sono nemmeno indirizzate a me.
Altri giorni Raquel sceglie l’italiano, ma non mi fa una grande differenza. Ci sono volte che nella strada di ritorno, quando Monte Morello ci si profila davanti, lei mi racconta del posto dove è nata e cresciuta, delle alte montagne che da nord a sud attraversano il suo continente. Io ascolto e non commento, che del resto di parlare non ho più voglia. Ho deciso che quando finirà l’estate ricomincerò a parlare, ma non prima. Allora spiegherò a Raquel delle montagne che ci sono da noi e le racconterò di quando i miei figli erano piccoli e d’estate andavamo lassù a cercare un po’ di fresco.
Oggi Raquel sembra essere di buon umore. Centra le buche, ma con uno spirito lieve, come se fosse un gioco. Mi sembra di riconoscere addirittura un certo entusiasmo. Io mi lascio trasportare attraverso le ombre dei palazzi e il tempo sembra immobile. Quando finirà l’estate i miei figli e nipoti torneranno dalle vacanze. Verranno a trovarmi qui a Sesto Fiorentino e usciremo tutti insieme fuori a pranzo. Andremo a mangiare da Dino, prima dell’Olmo, come sempre. Loro mi racconteranno delle ferie appena trascorse e delle loro speranze. Io li ascolterò e sarò felice per quel momento passato insieme. Raquel continua a trascinarmi sui marciapiedi sconnessi di Sesto, finché raggiungiamo come ogni giorno piazza del Comune. Si ferma un secondo sotto un albero, giusto il tempo di lasciarmi controllare che tutto sia rimasto al suo posto, poi con un gesto collaudato ruota la carrozzina di centottanta gradi in direzione di casa. E dietro-front. «Perché andate sempre in quella piazza, perché non cambiate?» mi chiedeva tempo fa mia figlia. «Ne hanno costruite di nuove» ha continuato, «potresti farti portare a vederle». Io allora le ho detto – era quando ancora avevo voglia di parlare – che per quanto mi riguardava, le piazze erano più che sufficienti.
Oggi Raquel sembra davvero di ottimo umore dal modo che ha di centrare le buche. Siamo alla svolta di Viale Michelangelo quando capita un fatto. Una cosa veramente da niente, ma che mi lascia perplesso. Un uomo che avrà la mia età incrocia il mio sguardo, è da solo e cammina con energia. Ha indosso un giubbotto pesante. Ci guardiamo un momento negli occhi, poi lui passa oltre, facendomi un gesto che non capisco, come volesse confidarmi qualcosa. Forse ci conosciamo? Siamo già lontani io e Raquel. Il caldo gioca degli scherzi alla gente. Anziani lasciati da soli, figli e nipoti in vacanza, così che i vecchi, quelli più sfortunati, quelli che non hanno una loro Raquel, perdono il filo dei pensieri. Povero l’uomo che esce d’estate con un cappotto pesante, solo e senza più il filo dei pensieri. Senza che riesca a impedirmelo mi si disegna sul volto un sorriso per la sventura toccata in sorte a quell’altro. Non è bello che io gioisca delle disgrazie altrui, mi dico, e la smetto. Stiamo quasi arrivati a casa. Raquel ha scelto di passare dal lato assolato della strada. Tra poco saremo arrivati, ma perché passiamo di qua? Perché non scegliere il lato in ombra? Mi vuol fare arrostire? Forse da questo lato della strada si vede meglio il monte? Una volta mi disse che le ricordava dove è nata. Forse Raquel ha contato che il numero di buche sul marciapiede è maggiore? Lo fa per punirmi, ma sono io che decido, non è lei.
Raquel dietro di me continua a spingere la carrozzina, quando succede un altro fatto: la vicina di casa, la vedova Chiostri, ha messo fuori dal balcone delle lucine intermittenti. Si direbbero quasi luci di Natale. Fanno un effetto strano, quasi come se fossimo nel paese di Raquel, dove festeggiano il Natale in piena estate. Sorrido di nuovo, stavolta per la stramberia della vedova Chiostri, che strana è stata sin da quando si trasferirono qua col marito trent’anni fa, ma ultimamente lo è ancora di più. E così siamo a due sorrisi cattivi. Raquel intanto procede, e mi parla di qualcosa che non afferro, cos’è che ripete? Signor Lisi, le piace la navi? Di che parla? Che c’entrano le navi? Mentre Raquel mi sfila le chiavi dal collo e apre il portone di casa girando le pesanti mandate, ripenso a quel vecchio col giubbotto pesante. Ripenso all’espressione che aveva sul volto, e se fosse stato un sorriso cattivo? Ripenso alle luci fuori dal balcone della signora Chiostri e alle parole incomprensibili di Raquel. Con un crescente senso di orrore ho il sospetto che questi fatti all’apparenza incoerenti si uniscano per comporre un disegno. Che se io tracciassi una riga tra le buche che centra Raquel potrei leggervi dentro una verità sulla mia vita, un messaggio tremendo, chiaro a tutti all’infuori di me. Con un gemito si chiude il portone alle mie spalle e penso un’ultima volta che quando i miei figli torneranno da me, chiederò se anche a loro l’estate quest’anno è sembrata tanto lunga.

Il suono del silenzio
Mirabili scrittori di scritte sugli accendini
dove trovate ispirazione per le vostre scritte?
Forse nelle sconfinate periferie di megalopoli cinesi
di cui nessuno mai conobbe il nome.
Posso immaginarvi camminare per strada con un lungo cappotto scosso
scosso lui e scossi voi
da venti cinesi,
ma forse non in quelle strade, non in quelle città di cui nessuno conobbe il nome, trovate ispirazione, mirabili scrittori di scritte sugli accendini,
bensì dentro di voi
nei vostri cuori di scrittori.
Come me, vi fermerete allora a un crocicchio di strade
sopraelevate e strade a sei corsie
scossi dal vento e appunterete su un quadernino rosso
su cui capeggia la scritta “Todo Modo”
con lentezza estrema scriverete l’ennesima frase perfetta
solo parole perfette
vent’anni tra un verso e l’altro
parole che poi arriveranno fino a me
tramite un minutissimo accendino:
il suono del silenzio.

Paolo Volponi e i benzinai brasiliani di Piazzale Donatello
Qui in piazza Donatello resistono due benzinai, fa strano dire resistono due benzinai, perché associamo il termine resistenza a concetti positivi mentre invece il benzinaio racconta di un’epoca di industrializzazione che speriamo col tempo anche di superare, che le auto vadano a energia elettrica, o meglio ancora solare, o con le pale eoliche, o che venga inventata una macchina mondiale completamente nuova, antica, ma nuova, e in conclusione che non ci siano auto come siamo abituati a conoscerle oggi.
Questo attacco vi sembrerà strano, ma vi garantisco che sto per parlare di Volponi, anzi ne sto già parlando, solo in un modo mimetico e non accademico, perché io accademico non sono e non è quello che mi è stato chiesto. Comunque dicevo che qui in piazza Donatello resistono due benzinai, già che in generale in città ce ne sono sempre meno. Qualcuno dirà speriamo resistano ancora per poco, va bene, qualcuno dirà che sono molto più cari rispetto ad altri, anche questo è vero, ma parlarvi oggi, qui, al cimitero degli Inglesi, parlare di uno di questi due specifici benzinai mi sembrava la giusta chiave per presentarvi Volponi, e mi spingo più in là: qualcosa che Volponi approverebbe.
Venendo nel senso di marcia, il mio consiglio è fermarvi al secondo benzinaio, non la sera o di notte, perché c’è il servizio automatico, ma durante il giorno, perché potrete vivere un’esperienza autenticamente volponiana. Ci lavorano infatti due benzinai, fratelli, forse addirittura gemelli, entrambi brasiliani e talvolta c’è anche il figlio di uno dei due, forse figlio di entrambi, che mantiene qualcosa di quello splendido accento del padre e dello zio, ma non è del figlio che ora vorrei parlare, quanto dei due fratelli. Sono brasiliani, e questo mi si dirà non è molto volponiano, (tecnicamente non credo Volponi abbia mai visitato il Brasile), a meno che non si voglia considerare il Brasile, rispetto a Piazzale Donatello, come un posto periferico, lontano, fatato quasi, inerente al passato dei due benzinai, e, arrischiandoci un po’, si potrebbe affermare che in un certo senso il Brasile sta ai due brasiliani come Urbino sta a Volponi.
Paolo Volponi infatti era nato a Urbino, nel 1924, e visse con questo luogo, che poi lasciò, un rapporto di amore e odio. Penso ad esempio al suo romanzo La strada verso Roma, con cui vinse il suo secondo Premio Strega, nel 1991, che racconta la vicenda di Guido, quasi un alter ego dello scrittore, che ama Urbino, ma vuole al contempo lasciarla per realizzare la sua ambizione (la sua ambizione, e forse redimere tutti, ma su questo punto torneremo). Così, mi piace pensare i due benzinai, vivono nei confronti del Brasile, un rapporto di amore, di idealizzazione, ma anche di rifiuto, ora che vivono qua: non tornerebbero indietro, amano il loro lavoro di benzinai, la loro vita è in Piazzale Donatello, Piazza che deve apparire loro come a Volponi appariva Roma o forse Torino, metropoli industrializzate, con tutte le differenze tra Roma e Torino che pure emergono nei libri di Volponi.
Urbino è certamente una delle grandi chiavi per intendere anche la produzione poetica di Volponi, sembra impossibile nella sua lunga produzione poetica, prescindere interamente da quella che è stata la sua infanzia e la sua adolescenza, diciamo meglio la sua giovinezza. Spesso infatti nelle sue poesie troveremo elementi legati agli animali, uccelli, volpi, o al paesaggio, e alle pratiche e alle persone che in quei luoghi hanno popolato l’infanzia e la giovinezza di Volponi. Ne hanno formato il carattere e per così dire definito per sempre la poetica. Non c’è tuttavia una semplice nostalgia, perché lo scrittore sembra vederne tutti i limiti, le problematiche, e queste le considera con la consapevolezza politica e sociale di un uomo del dopoguerra, del boom economico e di come questo boom non abbia raggiunto tutte le zone d’Italia, ma solo alcune, di una promessa disattesa. La prima raccolta poetica, Il Ramarro, scritta ancora ventenne è profondamente permeata da Urbino e dalle zone circostanti, dalle campagne, dalle colline e di nuovo dagli animali. La città è piccola, isolata dal resto d’Italia, da quelle che sono le grandi dorsali dell’industrializzazione, rappresentate sull’asse Milano, Torino, e dal centro di potere, Roma, le città dove in tanti si stanno trasferendo per cercare lavoro e nuove opportunità. C’è chi da Urbino, però, va via e deve andare ancora più lontano: era come è oggi anche una questione di privilegio, quindi chi può permetterselo andrà a Roma, come il Guido del romanzo, o a Torino, come Paolo Volponi, ma c’è anche chi dovrà andare in Belgio, a lavorare nelle miniere, come i contadini delle campagne di Urbino, i proletari. Così, posso dire ora io, le persone che lasciano il Brasile, si dirigono verso differenti destinazioni, e non ha senso indicare quali siano le mete più ambite, di certo l’Italia in questa classifica di luoghi sognati si trova più in basso rispetto agli Stati Uniti o all’Europa del Nord, ma sono congetture di cui so molto poco e lascerei da parte questa metafora, per adesso.
Paolo Volponi non ha avuto con la scuola, un rapporto semplice. Questo si legge nelle sue biografie, termina gli studi a fatica, riesce a laurearsi in giurisprudenza, ma senza entusiasmo; prova insofferenza per il mondo dello scuola, che lo rifiuta, e solo una sua passione individuale e pochi professori, l’amicizia con Carlo Bo, lo aiutano nel trovare una vocazione letteraria che lo accompagnerà per tutta la vita, facendo di lui un uomo che non fa dell’essere scrittore la sua unica occupazione. In questo mi sento dire, sento la chiamata di Elisa a parlare di Volponi, come una vicinanza tra noi, tra me e lui, perché anche per me la scrittura è qualcosa che non esaurisce la mia professione, non l’ha fatto in passato, quando lavoravo in una ditta di poste private, non lo fa oggi, che lavoro in una libreria, e credo non lo farà neanche domani. Questo chiaramente crea una distanza tra l’accademia e Volponi, che pure ha ricevuto tanti riconoscimenti e premi importantissimi, due premi Strega, come lui solo Veronesi, in anni ben diversi, in cui il premio Strega era ed è completamente differente, rispetto al passato, quindi per concludere questo punto, che forse spiega la mia ragion d’essere qui oggi, ne fa una figura non integrata, o non del tutto, quasi un outsider.
C’è però un altra stella polare nella vita di Paolo Volponi, ed è l’industria. Volponi ha avuto un intenso rapporto con Pier Paolo Pasolini, e oltre alla questione della letteratura, mi sembra si possa dire che tra loro ci sia stato un vivace dibattito culturale, finché Pasolini è stato in vita, e in particolare una differente visione su quanto riguarda l’industrializzazione. E qui, tra poco, tornano i benzinai brasiliani. Pasolini, come è noto, è stato il sostenitore della tesi della mutazione antropologica, secondo cui, la rapida e incontrollata industrializzazione, abbia fatto sì che il proletariato abbia assunto (la banalizzo un po’) la forma e i desideri della borghesia, in conclusione perdendo qualcosa della bellezza e della dignità che Pasolini riconosceva in loro. Mi sembra di poter affermare che Volponi abbia in questo senso una visione più ottimistica di quella pasoliniana, cioè che l’industria abbia un potenziale positivo, affermativo, emancipativo, forse questa sua visione è dovuta al fatto che abbia lavorato per vent’anni per Olivetti, che ha fatto sua istanze di un capitalismo, ma diciamo meglio, di un’industria illuminata e profondamente attenta a quelle esigenze dei lavoratori. In questo senso anche l’impegno politico di Volponi, l’aver militato tanti anni nel partito comunista italiano, rappresenta a mio avviso un elemento che denota non la sfiducia e il pessimismo di Pasolini circa la modernità e il lavoro, quanto invece una remota e forse oscura speranza che le cose potessero e dovessero migliorare. C’è in questo qualcosa che parla di quel boom economico di cui abbiamo già accennato, ma anche un nocciolo abbastanza misterioso, che rimane oscuro leggendo Volponi e che parla di Volponi stesso, ma che io ritrovo, pur non conoscendoli affatto, nei due benzinai brasiliani di Piazzale Donatello. Di solito infatti, chi si avvicina a un benzinaio al di là di fare benzina, ma con l’obiettivo di controllare l’olio o la pressione delle ruote, troverà nel tipico benzinaio italiano per lo più una faccia torva e un modo scontroso, quasi a conferma di un oscuro disprezzo e auto-condanna alla marginalità, un modo di fare che invece nei due benzinai brasiliani è completamente assente. Io, che vivo nei confronti del cambio dell’olio del mio scooter come una specie di paura ancestrale di fusione del motore, ho trovato in loro qualcuno da cui poter andare senza ricevere sempre musi lunghi e reprimenda, è il loro lavoro e lo fanno volentieri.
In conclusione ci sono in Volponi molti altri elementi che oggi non ho toccato, ma devo concludere dicendo che rimangono in lui, quando ci si approccia ai suoi romanzi o alle sue poesie, degli elementi misteriosi, ma direi di più, sembra che sia qualcuno che ha capito qualcosa della vita, che ha lambito una verità. Ha qualcosa che ci lascia un dubbio, un dubbio che è fecondo, e sebbene a tratti sia anche depressivo e sconsolante, come lo è la vita, sembra mettere sul piatto della bilancia, nel suo peso complessivo, qualcosa che fa pendere la vita verso un lato positivo. Non so dirlo meglio, ma è in conclusione questa la cosa più significativa che ho capito leggendo Volponi. C’è qualcosa di quel ragazzo predestinato, che alterna ombra e fulgore, che continua ad agitarsi in lui, una forza rinnovatrice, in quel suo modo d’essere specifico, antiaccademico, che non si trova bene a scuola, ma che ha una visione sua, terribilmente sua e unica, libera, forse potremmo dire “vitale”, innamorata di quello che vede, degli alberi, degli uccelli, delle donne, ma anche del rumore delle auto e della vita che scorre, e che mi ha convinto, in conclusione davvero, di provare a raccontarvi insieme a lui, di quei due benzinai brasiliani, che forse in questo momento, accolgono qualche automobilista con un sorriso e il loro accento esotico e musicale.
Grazie
23.09.2024
The italki class
A short story by S. for his English teacher Lorraine
At that time, a long time ago, my life was very good. I lived in Sintra, Portugal, in a little luminous apartment but for me it was a palace. I used to teach English lessons online and I had twentish students from all over Europe. I was happy, but at that time it wasn’t so obvious to admit to myself. Of course we are never happy in a complete way, because we are missing the 360 vision and we can only see a little portion, but now I can say that it was a beautiful life. On Thursday I used to go to Lisbon by train, and I had English class with a group of migrants in a ruined palace close to Rua Augusta. For the night I came back to Sintra tired but happy, with all those stories, with all the energy and the passion of these poor and unlucky people. I met my boyfriend and we spent time watching old noir movies or listening to him singing and playing guitar. The rest of the days I had my Italki classes with very different people from different cities all over the word, but mostly from Europe. Was it boring some days? Maybe. They were just middle-class people dreaming about a different life, and thinking that English could be a key to enter this fantasy new life. Was it possible to change their lives or was it just an illusion? Hard to say. I was just an English teacher, not a key. But for all of those students I could see on their faces a different dream, maybe not a clear dream, but just a shadow of it. They were just normal people with normal lives, like everybody. One of them, S. used to tell me a lot of incredible stories about himself. He was 40ish years old, and he spoke from a nice apartment in Florence, Italy. Apparently he was a writer, another day he was a stand up comedian, and on other days he was a poet. One day he told me about a poetic night with over fifty people watching him perform some ridiculous stories. I thought that all of those stories were bullshit. Nobody would pay one euro to listen to this guy, I thought. Maybe he was just a mythomaniac. His English level was so bad, although he thought he was a new Shakespear. One day, I remember because it was Thursday and after the class I had to go to Lisbon, S. told me that he had to quit his class because he had to go to Stockholm. Why? Are you going there for vacation? No, he contested, I’ll be there for the Nobel prize. Ha-Ha, I said. C’mon, is it for a vacation? Tell me the truth, just this one time. But he was crazy, and he didn’t admit that he was. We started to insult each other and we terminated our class for that day and forever. The day after, or maybe two, I saw in all the newspapers and on the internet that stupid guy and his stupid face on the stage of the Nobel Price Academy.
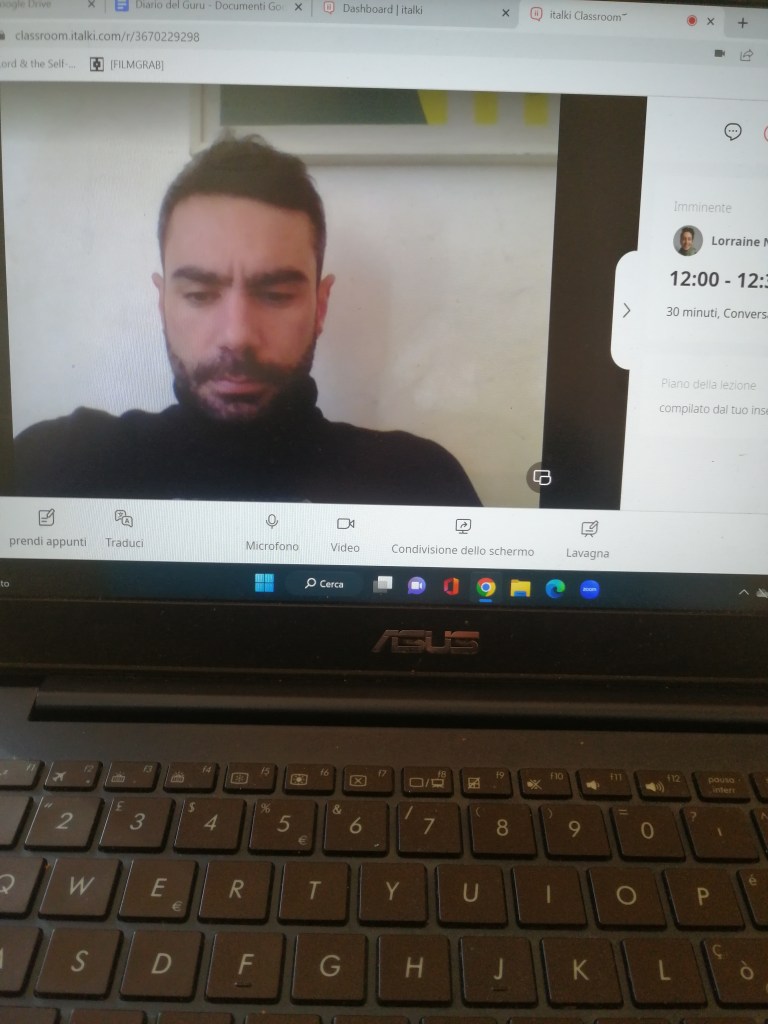
Al cimitero acattolico
Il binario non era ancora stato annunciato.
Guardavo il tabellone delle partenze, e mi guardavo attorno perché avevo appuntamento con mia moglie. Invece, tra la folla vidi il volto di Giacomo, il mio amico giovane. Stava fermo davanti a un binario qualsiasi, dove non partiva e non arrivava nessun treno. Mi avvicinai a lui per salutarlo, e venne fuori che prendeva il mio stesso treno per Roma.
Ma come, disse, ti avevo detto che avrei fatto il week-end a Roma.
Io annui, ma non ricordavo, o solo come una lontana informazione recepita in un momento confuso e messa da una parte, remota, nella mente. Sarebbe andato a trovare un amico, che a quanto diceva mi aveva presentato in passato, un critico musicale, o qualcosa del genere. Poi vidi arrivare Diana, e allora ci scambiammo saluti e io parlai della mia stanchezza, stanchezza che mi sembrava emanare come un calore dal mio viso e Giacomo disse qualcosa sul week-end a Roma e come mi avrebbe fatto bene. Uscì fuori anche il numero del binario, e ci dirigemmo tutti quanti verso l’11. Chissà, disse Giacomo, che non capiti che adesso ci troviamo seduti accanto.
A meno ce tu non viaggi in prima, disse Diana, noi abbiamo trovato i biglietti allo stesso prezzo e abbiamo preso quelli. Infatti eravamo seduti in altre carrozze e al momento di scendere dal treno, a Termini, io non pensai a fermarmi alla fine del binario ad aspettarlo, e ci dirigemmo veloci verso la fermata dei taxi.
Il giorno dopo, camminavamo con Diana in una giornata di febbraio fredda e limpida, tersa avrebbero forse scritto i poeti, dopo aver visitato un museo, ci aggiravamo nel mercato del Testaccio, cercando qualcosa da mangiare. C’era un clima lieto, ma ai nostri occhi sembrava tutto malinconico. Era probabilmente conseguenza della mostra che avevamo appena visto, su un esule documentarista che aveva ripreso quasi tutta la sua vita e aveva trovato poesia in molta di essa. Anche il mercato sembrava velato di tristezza, il suonatore di sassofono, un venditore ambulante di teste d’aglio, probabilmente di etnia sickh per la barba tinta con l’henneè, e mille altre facce giovani e vitali o vecchi e stanche che si muovevano in quel sabato mattina che già diventava ora di pranzo.
Forse la malinconia non si addice a Roma, aveva detto lei, e siamo noi che la vedremmo ovunque.
E a quel punto avevo di nuovo visto Giacomo. Camminava affianco a un ragazzo, il critico evidentemente, e non si erano accorti di noi, allora mi sono alzato da un tavolo e li ho raggiunti.
Che strana coincidenza, è la seconda.
Si sono seduti al tavolo con noi, e abbiamo parlato di cose a tratti futili e a tratti serie, della nostra differenza d’età, noi di dieci anni più vecchi, delle cose nuove che vedevano loro e che noi non vedevamo, di quello che invece noi con la nostra maggiore esperienza potevamo forse, chissà, aver capito, e ancora dei giovani ancora più giovani di loro due, che già gli sopravvanzavano, malgrado loro a tratti lo negassero, e di cosa questi novissimi dovevano vedere.
Poi per loro era ora di andare, ma prima di congedarsi Diana ha chiesto al critico musicale, romano, sebbene di un quartiere lontanissimo a quello in cui eravamo, un quartiere che non avevo mai sentito neanche nominare e che distava quasi due ore d’auto (cosa che rendeva quella seconda coincidenza ancor più radicale), Diana ha chiesto se lui avesse da consigliarci qualcosa là, nella zona.
Una cosa ci sarebbe, ha detto lui.
Poi quando ha finito di parlare, ci siamo salutati, dicendo: chissà se avremo ancora tempo d’incontrarci una terza volta, e convinti di no, ci siamo allontanati.
Il cimitero acattolico, diceva Google maps, distava solo sei minuti a piedi, ma il motore di ricerca mi indicava che fosse chiuso. Ho preferito omettere questa informazione a mia moglie e ci siamo incamminati ugualmente. Non so spiegarne il motivo, speravo fosse aperto, o forse semplicemente non riuscivo a pensare a un’alternativa. Parlavamo dei giovani, di Giacomo e del critico, che si sentivano così in cassa di risonanza col presente, e aggiungevamo noi, così poco consapevoli che pure quel momento stava passando. Noi ci sentivamo scollegati da tutto, ma per questo forse più in simbiosi con i pini silvestri che si stagliavano verso il cielo, o i murales disegnati sulle case o ancora le fila di monopattini elettrici parcheggiati dovunque, senza criterio e pronti a finire in delle discariche.
Abbiamo girato intorno alle mura del cimitero, non capendo dove fosse l’entrata e con la mezza idea, io, che ci saremmo fermati davanti al portone sbarrato. E invece era aperto.
Una ragazza all’ingresso con un grande sorriso e delle frasi ripetute molte volte ci ha indicato su una piantina le tombe dei famosi Keats, Shelley e poi ne ha aggiunti altri imparagonabili per importanza, ma che forse potevano interessarci. Noi abbiamo ascoltato distrattamente, poco attratti dalle tombe dei famosi, e piuttosto inclini a perderci tra le lapidi e i gatti randagi.
Camminavamo in silenzio e ho detto a Diana, Sai, ora ho come la sensazione, guardandomi indietro, a questo fine settimana a Roma, che incontrare Giacomo alla stazione, poi di nuovo al mercato, fossero coincidenze che servivano a incontrare il suo amico, il critico, che a sua volta ci avrebbe consigliato di venire qua. E quindi, forse ora, ho detto a Diana mentre lei cercava di avvicinarsi a un gatto acciambellato su un angelo di marmo, forse ora troverò qualcosa che mi parlerà, che mi dica qualcosa.
Certo, ha detto lei, è possibile, ma qualcosa di che genere?
Non saprei, ho risposto, se questo fosse un racconto, forse troverei una tomba con sopra scritto il mio nome.
Certo, se fosse quel genere di racconto, sì, ha detto lei.
Ma questo non è un racconto.
No, non lo è.
E allora cosa pensi che troverai in questo cimitero, tra queste bare e lapide scritte in tutte le lingue. Guarda là ce n’è una giapponese.
Non so, ho risposto.
Abbiamo continuato a camminare a lungo, io leggendo quelle scritte sulle lapidi come se fossero dei messaggi, dei messaggi per me, ho cercato e ho cercato, ma non ho trovato niente.

Nostra Signora della Provincia
«Insomma se ti sta tanto a cuore, chiediglielo», ha ripetuto l’uomo con il cappello di lana colore cremisi a quell’altro con i ricci che era stato in silenzio tutto il tempo, e mi sono domandato in quale fase della serata avesse così a lungo espresso il suo dubbio.
«Chiediglielo, che c’è da vergognarsi?» ha insistito ed era tutto vestito così. Anche i pantaloni in velluto e il maglione pesante. Tutto di quel colore senza che sembrasse una cosa strana o voluta.
Ma qualcuno glielo aveva fatto notare e lui aveva risposto facendo riferimento al gruppo musicale, o forse mi confondo. Si era parlato prima del gruppo musicale e di cosa volesse dire crimson, e solo dopo era venuto fuori che era interamente vestito di quel colore. Sia come sia «va bene» sussurra. «Allora se proprio non vuoi parlare, glielo chiederò io.»
E mi ha guardato negli occhi dicendo «il mio amico voleva sapere se siete una coppia o siete fratelli.»
Nel bar un breve silenzio, poi i presenti hanno aspettato che io rispondessi qualcosa.
Prima.
Il giorno prima Diana mi aveva chiesto se l’accompagnavo a San Mauro a vedere la mostra di un cubano, a una villa, e io le ho risposto va bene, andiamo, ma ho anche pensato che era una pessima idea. A San Mauro non ci torno mai, neanche a Natale.
C’è stato un periodo della mia vita in cui potevo concepire che i miei genitori morissero, ma non di vivere altrove. Poi siamo partiti. Prima io e poi loro.
Diana lavora nell’arte, o meglio ci prova. Era sul divano che guardava le mostre da recensire e mi ha detto se avevo voglia di accompagnarla a San Mauro e io le ho detto sì. Siamo arrivati al paese che già era sera.
La mostra.
La mostra era finita prima ancora di entrare, perché nel vialetto d’ingresso l’artista aveva esposto tutto quello che di buono aveva da dire. Cioè prendere robaccia marcia trovata lungo il corso del fiume fatta come dei nodi, grumi di cose come quando i legni e la roba si incastrano all’altezza dei ponti. La gente del luogo, passando per strada, si lasciava andare a facile ironia mentre una volta dentro la villa le luci e i grandi disegni li paralizzavano.
«Posso immaginare» mi aveva detto Diana, «che la gallerista abbia detto al cubano belle le tue installazioni, ma mica si vendono. Di queste tue cose ora mi fai dei quadretti. Niente di particolarmente grande, magari due o tre enormi se ne hai voglia, ma comunque sì: l’ideale sarebbero un bel po’ di quadretti» e lui aveva accettato. Forse la ragione stava nel fatto che l’artista era nato il mio stesso anno e anche lui aveva capito come quadretto fosse sinonimo di compromesso e che compromesso fosse sinonimo di vita.
Anche se a questo proposito con Diana ci eravamo avvicinati, anzi Diana da sola per chiedere se avesse scelto San Mauro o se San Mauro avesse scelto lui, visto che le sue opere erano proprio in cassa di risonanza a certe derive industriali e fluviali che ben definivano il luogo, ma a me sembrava una domanda insensata, come se il peyote trova te o te il peyote.
Il cubano le aveva risposto qualcosa, ma lei non parlava spagnolo, insomma pochissimo e non si erano capiti (come d’altronde avrebbe potuto capire una domanda insensata?) e lei mi aveva fatto un cenno, anzi prima un cenno e poi preso per mano e portato fino davanti al cubano, per capire cosa le stesse dicendo. Io gli avevo detto hola, que tal, ma lui si era come scordato del compromesso con la realtà e dei quadretti e ci aveva liquidato dicendo che la conferenza stampa sarebbe iniziata ahorita e allora avremmo potuto fare qualsiasi domanda avessimo voluto.
Aspettando che cominciasse eravamo usciti nell’ampia terrazza dietro la villa, che poi si era rivelata essere un terrapieno sulla sponda del fiume, ed eravamo stati là a guardare nel buio il chiarore dei sacchetti di plastica appesi agli alberi lungo la riva del fiume come creature notturne o installazioni di artisti meno compromessi del cubano, che comunque, diceva Diana per giustificarlo, era «solo molto timido.»
Ci eravamo allontanati dalla villa con ancora tutti quei discorsi negli occhi: la voce del cubano sovrastata da quella dei politici e sindaci e dei sindaci dei paesi vicini, e dei curatori, e dei galleristi e dei critici amici di Diana, tutti là a parlargli sopra, sopra quell’angolo di stanza completamente stipato di scarpe buttate e spaiate e Diana a quel punto non aveva retto più. Era venuta a cercarmi e mi aveva trovato seduto fuori per le scale, ad aspettare che finisse. C’era una comunità di rifugiati che aveva aiutato il cubano a raccattare la roba lungo il fiume, ed erano alla mostra completamente fuori contesto, con i loro vestiti migliori, ma in effetti anche la gente di San Mauro lo era: tirata a lucido e pacchiana.
Io pensavo solo: eccola qua, Nostra Signora della Provincia.
Stavo sulle scale ad aspettare Diana che non sarebbe riuscita a fare quella sua unica e insensata domanda sul trovare o essere trovati, e c’era accanto a me un tipo nero se non che era albino, che si era sentito in imbarazzo ad andare con gli altri ragazzi di colore a farsi vedere tipo esposizione universale e sedevamo accanto senza parlare, ognuno aspettando qualcuno, e io pensavo soltanto se quel tipo fosse un segno di malaugurio o se invece l’opposto, ma no, era certo malaugurio perché ogni profezia non può che recare cattive notizie.
Poi Diana era tornata incazzata e la nostra visita alla mostra era finita.
«Mangiamo qualcosa, già che siamo qui?»
«Sì»
«Andiamo a San Mauro Alta?»
«Sì. In verità», ho continuato, «non si dice San Mauro Alta. Esiste solo San Mauro e San Mauro Bassa. Serve a definire dei livelli sociali che non possono essere scalfiti né, in un certo senso, comparati.»
«Ah già. Tu sei di qui, no?»
«Sì. Ero di qui.»
«Non si dice ero di qui. Si dice di un morto. Un vivo è e rimane di un posto.»
«Anche se non ci torna mai più?»
«Sì.»
«Come un cubano con Cuba?»
«Esatto.»
Così siamo andati verso il sabato sera di San Mauro a cercare un posto dove lasciare la macchina, ma come non trovare posto per la macchina a San Mauro? E mostrare con il dito a Diana alcune cose che pensavo in mia assenza si fossero spostate come i ghiacciai sulle montagne, ma invece erano sempre rimaste lì.
«Vedi quei bar? Sono nuovi.»
«Uao.»
«Invece certi lavori a loro modo epocali, come questo ascensore che porta al parcheggio giù in basso, io a quel tempo ero presente, quando lo fecero.»
«Ah sì?»
«Sì. Chissà che pensavano in Comune. Quante macchine sarebbero arrivate. E invece poi anche quella cosa era passata, le macchine avevano raggiunto il limite.»
A dimostrarlo il parcheggio giù in basso semideserto, come una promessa di felicità disattesa.
«Allora proviamo qui?» e siamo entrati nell’osteria che sembrava mezza vuota. Ma né all’osteria, né alla pizzeria dentro l’ex-cinema fallito siamo riusciti a trovare un posto libero. La crisi in paese era solo esteriore, così abbiamo provato all’unico bar dove non volevo andare perché sapevo che avrei trovato qualcuno del mio passato, e infatti là c’era posto a sedere.
Il bar Burro e Acciughe era vuoto, fatta esclusione per uno di spalle che sembrava in tutto distaccato da sé e dal contesto e che unicamente dopo ho riconosciuto come un vecchio conoscente.
«Ehi, ti ricordi? Come va?»
«Benissimo» ha risposto, «molte e grandi soddisfazioni. Sto veramente bene. Mai stato meglio.»
«Bene» ho detto io, «mi fa piacere saperlo.»
Ma poi, dal modo in cui lui ha piegato il capo pieno di riccioli e gli occhi schiacciati, ho capito che non era vero, che stava male e che era ubriaco. A quel punto lo hanno raggiunto nel bar anche l’uomo pelato con i baffi e i vestiti che tendevano al rosa, ma ancora non sospettavo fossero cremisi. Poi un altro più vecchio, con un piumino, tutti e tre con le rispettive bottiglie in mano. Io ho cercato di disinteressarmi e concentrarmi sul menù, di mostrarmi assorto quanto meno agli occhi di Diana, ma non era semplice. Dopo qualche minuto l’uomo con i baffi ha fatto la sua domanda sulla natura del nostro rapporto, senza mai cambiare espressione, anche se in verità l’altro con i ricci non doveva avergli chiesto proprio niente, e di certo non aveva fatto caso che io e Diana ci somigliassimo. Perché neanche ci guardava. Ho spiegato che eravamo una coppia e che non ce l’aveva mai detto nessuno, che fossimo simili.
«Magari dopo un po’ si comincia ad assomigliarsi. Come nelle isole o nei piccoli paesi» ho spiegato tanto per dire qualcosa.
Siamo rimasti nel bar il tempo di finire i panini e ancora qualche discorso, poi siamo usciti. Mentre scendevamo nella strada che portava al bar centrale Diana ha detto «che cosa incredibile è appena successa. In città non sarebbe mai capitato di parlare così con qualcuno semplicemente perché ti si trova vicino. Ti sei accorto?» ed io «sì. Te dici che cosa bella, ma a me mi è sembrato un incubo. Che stavolta siamo stati solo un momento vicini, ma che se vivessimo qui non ci saremmo più liberati di quei tre.»
E, come a conferma delle mie parole, è ricomparso l’uomo con i riccioli accanto al bancone del bar e ci ha guardato come a chiedere una carezza, ma io non avevo niente da dire, e lui non ha detto niente, limitandosi a mostrare alla barista dagli avambracci pelosi i suoi soldi, come a sottolineare «ce li ho», e io e Diana abbiamo preso le nostre tazzine e ci siamo spostati a un tavolo più in là, per restare da soli, quasi fossimo nuovamente in città.
«Non hai detto niente a quel tuo vecchio amico?»
«E che gli dovevo dire?»
«Ma che cosa aveva? Perché stava male?»
«Saranno tormenti d’amore», ho risposto.
«Sono tipici qua in provincia.»
Usciti dal bar per tornare in città, il paese che era sembrato così vivo fino a un attimo prima era buio e vuoto.
«Che belle queste scale», ha detto Diana.
«Sembra di stare a Parigi.»
«È vero» ho detto io, «ma adesso andiamocene» e mi sembrava che qualcuno ci venisse dietro. Di certo, ho pensato, era ancora l’ubriaco coni ricci che camminava per le strade tipo un vascello fantasma.
«Perché hai lasciato San Mauro?» mi ha domandato Diana che già entravamo nel parcheggio deserto.
«Cosa è successo?»
«Beh. La gente» ho risposto. «Non ti lasciano in pace, li incontri dovunque, ogni giorno, sempre gli stessi. Bisogna partire, andare lontano, e così ho fatto.»
«Sì, ma in concreto: che cosa ti ha spinto? Quale occasione? Perché dai tuoi racconti d’infanzia sembrano tutto l’opposto: campagne dove ci sono soltanto bambini e i genitori tutti a lavoro. Mattine lunghissime a risalire la collina.»
«Eh» ho detto, «se non ci nasci fai fatica a capire.»
Tenendo Diana per la manica siamo entrati nel parcheggio, e dietro quell’ombra. «È che le persone in provincia non sono come in città: si ricordano tutto. Te gli dici una cosa, ed è quella. In verità non sono cattive. È che si annoiano. Allora cercano lo scontro, la mettono sul personale. Come fare a non mettersi sul loro piano? Uno dovrebbe evitare, poi ti rigiri e fai peggio.»
«Non capisco. In che senso?»
«Che ci fate a San Mauro?»
«Siamo venuti per la mostra. Anzi in verità io qui ci sarei nato.»
«Ah, ritorni eccellenti.»
«E venite proprio dalla città? O da qualche quartiere periferico?»
«Città.»
«Le opere di un tipo cubano.»
«Alla villa accanto al fiume.»
«Era bravo il cubano?»
«Promettente.»
«Non ho mica capito se vi è piaciuto.»
«Siamo venuti a vedere.»
«A vedere e farvi vedere.»
«Come dici?»
«Lo so come funziona quel mondo. Non è mica un segreto. Il sindaco, il cugino, gli amici del sindaco.»
«No, veramente.»
«Vi dico che ci ho avuto a che fare. Lo so che è così.»
«Solo a vedere un artista esiliato, non a sentire i discorsi» ha detto Diana, ma era dubbiosa. Allora sono intervenuto, perché avevano iniziato loro. Erano stati i primi a essere scortesi e ho fatto la sola domanda che sapevo non dovevo fare.
«E voi ragazzi, che fate di bello stasera?»
Ancora silenzio, quindi il pelato vestito di rosa mi ha detto «pensi che ci sia qualcosa da fare a San Mauro?»
«Chiedevo soltanto» ho spiegato, evitando il suo sguardo.
«Io questo l’odiavo, questo dirsi le cose precise che fanno più male» ho detto a Diana camminando veloce nel parcheggio in penombra. «Ma forse» ho continuato, «anche io sono fatto così. Rimugino, penso che gli altri si facciano gioco di me. Un complesso. Qualcosa di tipico nelle persone di bassa statura o che vengono della campagna. Pensiamo che gli altri lo capiscano subito, che siamo gente da niente. Allora ci prende la cattiveria, quest’odio da bisce di fiume.»
«Ma che dici?»
«Vieni Diana. Voglio tornare a casa» le ho detto riconoscendo tra le altre la nostra automobile parcheggiata.
L’uomo con i baffi stava appoggiato alla portiera che si massaggiava la testa pelata. Appoggiato alla macchina e c’era anche l’altro con il piumino e impugnavano le bottiglie di birra finite come a volerle lanciare.
«Ecco che arrivano i fratellini» ha detto quello più vecchio che era stato zitto per tutto il tempo, mentre l’altro con i ricci è comparso dal retro del parcheggio e ha singhiozzato un lamento.
Per alcuni secondi nessuno ha parlato, e io ho pensato al cubano e alle sue opere ignorate da tutti, che ancora stavano là nel vialetto d’ingresso. Poi ho detto pianissimo più a me stesso che a Diana che mi stava vicina «ora guardala bene, cos’è la provincia.»

